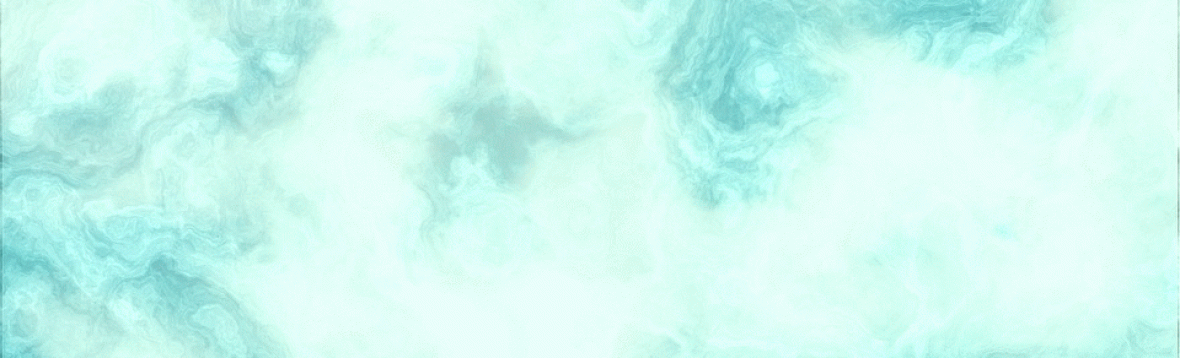“Antichi Astronauti in Sudamerica – Tracce di Contatti nel Passato” (di seguito A.A.S. ) di Filippo Sarpa e Sara Rolando (editore XPublishing) è un saggio in due volumi che si propone di illustrare la teoria del titolo. Sono chiamati “antichi astronauti” i viaggiatori provenienti da altri mondi che in un remoto passato (e anche in tempi più recenti) visitarono il nostro pianeta lasciando un’ ”impronta” indelebile nelle culture, tradizioni, religioni e tecnologie dei nostri antenati. Si tratta di una teoria non supportata dal mondo accademico, ma di certo non più di nicchia, visto il successo avuto da alcuni saggisti che l’hanno divulgata (von Däniken, Sitchin per dirne un paio) ed altri che le hanno strizzato un occhio (Hancock, Bauval, West, ecc…). La teoria non ha una propria forma delineata, ma contorni sfumati (come spiegano anche gli autori di A.A.S.) che vanno dal contatto con extraterrestri alla semplice presa d’atto che qualcosa nella storia dell’umanità non torna, fosse anche solo per il retaggio di antiche civiltà evolute, scomparse di fatto e dalla memoria.

Nella prefazione il saggio viene presentato come suddiviso in macrocapitoli: una introduzione alla teoria, con un tentativo di definirla partendo dalle origini; una valutazione dell’impatto socioculturale; una presentazione dei luoghi di interesse, visitati di persona dagli autori in un viaggio recente in sudamerica, con a corredo alcune interviste ad esperti degli argomenti trattati; interpretazioni di quanto emerso dalla ricerca sul campo e analogie.
Sostanzialmente quest’opera è una sintesi delle tesi di laurea dei giovani autori, tanto che non ho ben capito cosa c’è in più o in meno nel libro, ma non è importante.
La prima ragione che mi ha spinto ad acquistare il primo volume è stata l’argomento trattato, di cui non sono né un esperto né un vero appassionato (o forse si?), che da sempre mi incuriosisce e stimola; la seconda è stata la data di pubblicazione, perché cercavo qualcosa di aggiornato.
E magari anche qualche nuovo autore meno noto alle masse.
All’inizio la lettura non è molto scorrevole: la poca enfasi, le tante informazioni condensate in poche pagine, la puntigliosità eccessiva mi hanno un po’ annoiato. Mi è sembrato un po’ che gli autori non sapessero da che parte stare, tra l’”incudine” della passione per una teoria non convenzionale e il “martello” del rigore accademico, quasi in conflitto con sé stessi. Ma l’impressione iniziale ha ben presto lasciato il posto ad un percorso interessante seguito dagli autori nel loro viaggio. Certo che se si è abituati alla fantasia di Sitchin, qui siamo all’estremo opposto, ma c’è comunque una grande abbondanza di informazioni interessanti. Ovviamente ci si sofferma più sui particolari che sull’insieme, perché è l’unico modo per far emergere le anomalie che l’archeologia convenzionale ignora.
Nonostante l’abitudine acquisita all’impressionarmi per la magnificenza di grandi opere di costruzione, mura mastodontiche e disegni giganteschi sul terreno, sono stati proprio alcuni piccoli dettagli che non conoscevo a sorprendermi. Un po’ come quando leggendo i libri di Piccaluga su Marte non riesci a vedere tutti i volti che lui ti mostra sulla superficie del pianeta, ma rimani a bocca aperta per dei muri a novanta gradi.
La scienza ortodossa dell’architettura e delle tecniche di costruzione non attribuisce agli Inca una tecnologia per rendere malleabile le rocce, magari usando fornaci ad altissime temperature, eppure alcune delle suddette anomalie non sarebbero tali se tenessimo conto anche di questa possibilità.
E non parlo solo della precisione ad incastrare i blocchi rocciosi l’uno con l’altro, come nella nota pietra a 12 angoli di Cuzco.

Non posso inserire foto dal libro (e non ne ho trovato su internet), ma mi ha lasciato basito “El ocho” (= l’otto) nel parco archeologico di Sacsayhuamán (Perù), che non è altro che un buco nella roccia con una forma particolare, scavato dall’alto al basso. La caratteristica peculiare è che presenta un bordo rialzato in mezzo ad un piano completamente levigato: comprensibile alla stregua di un buco nella terra se si si immagina che sia stata utilizzata una qualche tecnologia per rendere malleabile la roccia; quasi inspiegabile se si deve credere che, senza un motivo specifico, sia stato rimosso a colpi di scalpello il materiale roccioso su tutto il piano circostante, lasciando solo questo bordo.
Per la stessa ragione lasciano perplessi gli scoop marks (“marchi di paletta”), ovvero “depressioni sulla superficie della pietra che sembrano il risultato della pressione di utensili dalla base quadrata o rettangolare” come spiegano gli autori: sembra proprio che qualcuno abbia giocato con paletta e secchiello con la sabbia bagnata, pur sapendo che si tratta di roccia difficilmente lavorabile.
E che dire delle protuberanze sui blocchi rocciosi nel Coricancha e ad Ollantaytambo, ma anche in numerose opere attribuite agli Inca?
Anche i segni di vetrificazione (visibili e tattili) sui blocchi corroborano la teoria delle alte temperature per fondere la roccia.
Si prosegue poi in volo sulle linee di Nazca, poi in Bolivia e fino all’isola di Pasqua, ma lascio ai lettori il piacere di accompagnare gli autori in questo viaggio.
Interessanti anche le interviste, anche se tutte pro antichi astronauti: sarebbe stato interessante anche sentire anche l’altra campana per un confronto diretto.
Alla fine direi che è un saggio che mi sento di consigliare se si ha un minimo di interesse per l’argomento ed è comunque degno di rispetto per l’importanza dei dubbi che vengono sollevati, la soluzione dei quali potrebbe portare a riscrivere la storia.
Faccio inoltre i migliori in bocca al lupo ai giovani autori per il coraggio incitandoli a continuare su questa strada.